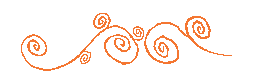di
Annalisa Fantini
A volte il corpo prende
a bruciarmi come un tempo. Un prurito insistente che diviene fuoco non
appena comincio a strofinarmi forte con i polpastrelli. La pelle è
una terra di confine, il bordo estremo fra il palpito del cuore e il mondo
esterno. Quando il corpo brucia, la pelle diventa rossa, a chiazze viola,
a volte s'ispessisce in piccoli bozzi dove sembrano covare vecchi rancori.
Prendo dei medicinali, ma cerco di evitarli perché mi fanno gonfiare.
Era molto tempo che non mi accadeva. Ho cambiato città, adesso vivo in un piccolo capoluogo del Italia meridionale dove la vita meno frenetica e un minor inquinamento aiutano la mia salute. Vivo abbastanza bene, sono come una gatta dalle sette vite e quella di ora è solo la quarta. Me ne restano ancora tre. Nella mia terza vita, a Milano, i pruriti erano insistenti e dolorosi, ma mai quanto quelli di Elizavac, un piccolo villaggio croato vicino al confine ungherese, dove mia nonna Anna e zio Marko hanno portato me e mia sorella Snijézana strappandoci dall'inferno di Sarajevo.
Sono nata nel 1978, il giorno di Natale. Da piccola non ho mai festeggiato il compleanno perché mia madre temeva che si potesse confondere con la celebrazione religiosa. Gli ortodossi ricordano il Natale il 7 gennaio e i comunisti non ne vogliono sentir parlare.
La mia famiglia era composta da mio padre, Stijepa, colonnello dell'esercito bosniaco, di etnia croata, mia madre Jana, tenente dello stesso esercito, serba, mia sorella, di due anni maggiore e io, arrivata per salvare il matrimonio dei miei genitori. La prima missione l'ho inevitabilmente fallita.
La mia città, Sarajevo, era bellissima. Abitavamo a Grbavica, un quartiere moderno, che oggi è famoso per essere stato la roccaforte dei serbi e dei loro cecchini. Ho visto sparare alle finestre, ai portoni, ai cani che passavano, alle persone che correvano. Ho visto morire per strada i miei vicini di casa, due compagni di classe, sconosciuti con i cappotti insanguinati, ho sentito il crepitio dei kalashnìkov sui muri dei palazzi, le urla di coloro che erano portati via con la forza.
Alla fine non c'era più nessuno a difenderci. Mio padre era stato dichiarato disperso e mia madre era sparita. Un giorno non è tornata a casa. La credevamo morta, ma guardando la Tv, che trasmetteva filmati girati nelle strade di Sarajevo e che in tanti guardavamo in cerca di persone care, mia sorella e io abbiamo visto una donna che c'è parsa la mamma. Un uomo l'aiutava e stava salendo su un mezzo di trasporto. Tutto questo avveniva in tempo reale nell'isolato accanto al nostro. Partiva per fuggire dalla guerra. Mi hanno detto che è viva e che abita a Belgrado.
Nella mia prima vita ho fatto la conoscenza con la razza dei giornalisti. Soprattutto gli americani. Venivano con i loro sorrisi a girare immagini dei " bambini di Sarajevo" che si sfamavano con una ciotola di latte della Croce Rossa. Tiravano fuori i loro snack, lattine e bibite senza mai offrire, regalare, barattare con un sorriso. Gli italiani erano un pochino diversi, ma tutti, proprio tutti, erano così interessati ai loro servizi da dimenticare che loro sarebbero partiti e noi rimasti lì senza la certezza del presente e, dunque, senza futuro.
Mi sentii male la prima volta in una serata di primavera. Dicevano che almeno il tempo stava volgendo al meglio quando un forte senso di nausea mi scagliò sul muro alle mie spalle. Sentivo caldo e mi sembrava di non respirare bene. Il prurito cominciò dal collo, poi le spalle, le braccia, le gambe, la schiena, il petto, il ventre, tutto prudeva, tutto bruciava, dentro e fuori. Mi condussero all'ospedale e diagnosticarono un avvelenamento da polveri, non meglio identificate. Snijézana riuscì a raggiungermi e restò per molti giorni seduta accanto al mio letto. Dormiva appoggiando la testa sul cuscino, accanto a me. Qualche volta si stendeva.
Miglioravo. Sapevamo che di lì a qualche giorno mi avrebbero dimesso per affidarci ad uno dei tanti centri di raccolta di profughi e orfani. Saremmo diventate un numero, magari consecutivo; non ci piaceva nemmeno un po'. Sentivamo parlare di stupri, di sparizioni, di quello che i Serbi continuavano a perpetrare nella nostra terra. Abbiamo visto donne di tutte le età, fantasmi a cui avevano tolto anche l'anima, raggomitolate in quei letti come fagotti, restare lì per giorni senza mangiare, senza piangere. Snijézana, che di noi due è la più saggia, mi diceva che in fondo eravamo fortunate, a noi non era toccato. Si presentò una mattina mio zio Marko, uno dei fratelli di mio padre. Ci portava nella Croazia pacificata, nel paese natale della mia famiglia, Elizavac, che è un piccolissimo villaggio dove metà della popolazione è nostra parente. Lì c'è mia nonna Anna che ci ha preso con sé e ci ha insegnato a vivere.
La mia seconda vita si alimenta di mia nonna. Oggi è quasi novantenne, analfabeta, ha visto più guerre che giorni di festa. Ha partorito sette figli, due morti alla nascita, uno nel conflitto contro i Serbi( mio padre), una in un incidente stradale e il piccolo Mirko, sparito cinquant'anni fa nel bosco vicino a casa. Sembra un'orribile favola, ma gli orchi esistono davvero. Quello è stato il dolore più grande della sua vita. Mia nonna Anna, che conosce acqua corrente ed elettricità solo da pochi anni, ci ha rimesso in sesto a forza di salsicce e fagioli conditi con preghiere e candele accese alla Madonna. Credo ancora in Dio( che per me significa speranza) per lei, che è la creatura più cara e dolce e forte sulla faccia della terra. In questa vita croata ho studiato nelle scuole dei paesi del circondario e ho vinto una borsa di studio per l'Italia. Grazie agli accordi fra il Bel Paese e la Croazia avrei potuto frequentare la scuola superiore a Milano. Vedevamo, senza comprenderne la lingua, i programmi e la pubblicità italiani pieni di persone belle ed eleganti, di città magnifiche e di gatti che mangiavano in scodelle dorate. Lasciai con dispiacere mia sorella, che ha continuato a studiare in Slovacchia, il Paese d'origine di mia nonna. Oggi si è laureata in lingue a Bratislava ed è tornata ad insegnare inglese e slovacco nelle scuole di Elizavac e dintorni.
Il viaggio verso l'Italia era carico di sogni e di attese. Avrei fatto parte di una famiglia con due figli, una ragazza e un ragazzo della mia età ( avevo sedici anni) e avrei studiato in un istituto tecnico con indirizzo turistico.
Mi accorsi ben presto che la lingua italiana era molto difficile e che non riuscivo ad impararla in fretta perché nessuno parlava con me. A scuola mi vedevano come una zingara o un'albanese sbarcata dal gommone, a casa ero costretta a passare il pomeriggio nella mia stanza, potevo uscire solo per la cena. La domenica dovevo andare a Messa con la famiglia ospite che esibiva, così, una volta la settimana, tutta la bontà dei sentimenti di accoglienza e il valore della solidarietà.
La mia terza vita è stata umiliante, ma sono testarda e non accetto facilmente la sconfitta. L'Italia è bella e io dovevo trovare il modo di scoprirlo. Anche la Jugoslavia ( che emozione chiamarla ancora in questo modo…) è bella, ma non esiste più e non volevo tornare in quell'inferno. Lo avevo giurato a me e a mio zio Marko che quando sono andata a trovarlo mi ha chiesto: " E allora, abbiamo scoperto quanto sono bravi gli italiani? Quei tre ancora vivi che non sono mafiosi!...".
In quattro anni ho cambiato altrettante famiglie. Mancava solo il quinto al diploma, quando gli accordi internazionali sono saltati e mi sono ritrovata in un Paese che mi considerava straniera, senza titolo di studio e senza possibilità che il governo croato convalidasse i miei anni di scuola. Ho trovato lavoro come baby-sitter presso una famiglia che gestiva una trattoria sui Navigli. La mattina spesso saltavo le lezioni perché la piccola di diciotto mesi di cui avevo cura mi faceva passare la notte in bianco; nel pomeriggio, quando dormiva, dovevo stirare le tovaglie del locale, per me c'era sempre qualcosa da fare.
Mi sono diplomata, ho trovato lavoro in una profumeria e sono andata ad abitare con altre tre ragazze in una vecchia casa dalle parti di Porta Venezia. Per la prima volta ho avuto una mia vita. Lavoravo, uscivo con gli amici e fra questi ho conosciuto Daniele che studiava in un'università prestigiosa e veniva da Lecce. La sera in cui l'ho incontrato avevo indosso un maglioncino di cotone per difendermi dal prurito, ma inspiegabilmente la sua compagnia mi rendeva quieta e fresca. Dopo pochi mesi sono andata a vivere con lui, ho trovato un lavoro fisso che ho deciso di abbandonare quando Dado si è laureato ed è tornato a casa per lavorare nella piccola azienda di famiglia. Gli amici mi hanno sconsigliato di mollare un impiego sicuro, di prendere tempo, ma chi ha un'esperienza come la mia sa che la felicità dura poco, pochissimo e che nulla, che si nutra di vita, è immutabile, ma neppure irreversibile. Il prurito era diminuito molto e respiravo meglio.
La mia quarta vita a Lecce è cominciata male. Gli affari di famiglia di Dado andavano sempre peggio, suo padre aveva troppi debiti. Ci siamo rimboccati le maniche. Lavoravo in una tavola calda e Dado, pian piano, con l'aiuto di uno zio ha cominciato a risolvere i problemi finanziari. I nostri rapporti erano tesi perché lui, che non era abituato a guadagnarsi il pane, pretendeva di vincere le ingiustizie.
Abbiamo una casa che ci ha messo a disposizione la nonna paterna, con noi c'è anche qualche amico e ora lavoro in un negozio di abbigliamento, a tempo indeterminato. Fare la commessa non è una gran cosa, ma mi permette di vivere e, poi, so che cambierà ancora. L' azienda di famiglia va meglio e credo che fra poco avrò la possibilità di impiegarmi in un ufficio della stessa ditta. Pensiamo al matrimonio, ai bambini che avremo, a mia sorella che la prossima estate verrà a trovarci con la mia prima nipotina che ha due anni e si chiama come me, Anja.
Qualche volta mi gratto e mi assale la paura che quei rigonfiamenti, quel bruciore possano tornare.
Francesca, la mamma di Dado, mi ha spiegato che le analisi dicono che le polveri inalate e prese per contatto durante la guerra non sembrano aver procurato veri danni. Che, in realtà cerco di "sfogarmi" per tutto quello che ho patito. Forse ha ragione. So che mi vuole molto bene e che vorrebbe stringermi fra le braccia, cullarmi, essere per me la mamma che non ho avuto. Glielo lascio fare solo un pochino, non perché non mi fidi ( non mi fido di nessuno) ma perché una figlia bisogna guadagnarsela. Chi la mette al mondo crede di avere le ragioni dell'amore e del sangue, chi la trova nel suo cammino deve accettare che sia solo lei a concedere il diritto di amarla. Francesca fa di testa sua e mi ama lo stesso.
L'altro giorno la pelle ha ricominciato a bruciare forte. Ho dovuto grattarmi e, benché abbia imparato a farlo con i polpastrelli, non ho potuto evitare di graffiarmi. Ho preso di nuovo i medicinali e mi sono chiesta cosa avessi respirato, o toccato. O ricordato. Non mi è venuto nulla in mente se non una musica che veniva dalla scuola di danza sotto casa mia. Una melodia orientale, un violino, forse il leit-motiv di una bella pellicola sull'ultimo imperatore cinese. A Sarajevo mio padre aveva alcune musicassette con le colonne sonore di film famosi, forse c'era anche quel brano così dolce e struggente. Le medicine hanno fatto effetto e il prurito è scomparso.
Leggo dei libri di psicologia, mi piacerebbe saperne di più sui meccanismi che tengono in equilibrio il corpo e la mente. Immagino che il mio problema sia una corazza, non un'armatura esterna, ma una latta interiore che blocca certi flussi, certi umori, che ristagnano e s' incendiano. Ne vorrei parlare con mia sorella e sapere se anche lei ha maglie e cotte che la legano.
Verrà in vacanza da me la prossima estate, porterà la mia bellissima nipotina e quel marito così alto con la faccia da slavo. Gli presenterò il mio ( non siamo ancora sposati) che ha un bel viso mediterraneo. Fingeremo di giocare a signore, come quando da bambine, nel cortile di un grande caseggiato, pensavamo di portare le nostre bambole in vacanza sui monti della Slovenia o sulla costa del Montenegro.
Era molto tempo che non mi accadeva. Ho cambiato città, adesso vivo in un piccolo capoluogo del Italia meridionale dove la vita meno frenetica e un minor inquinamento aiutano la mia salute. Vivo abbastanza bene, sono come una gatta dalle sette vite e quella di ora è solo la quarta. Me ne restano ancora tre. Nella mia terza vita, a Milano, i pruriti erano insistenti e dolorosi, ma mai quanto quelli di Elizavac, un piccolo villaggio croato vicino al confine ungherese, dove mia nonna Anna e zio Marko hanno portato me e mia sorella Snijézana strappandoci dall'inferno di Sarajevo.
Sono nata nel 1978, il giorno di Natale. Da piccola non ho mai festeggiato il compleanno perché mia madre temeva che si potesse confondere con la celebrazione religiosa. Gli ortodossi ricordano il Natale il 7 gennaio e i comunisti non ne vogliono sentir parlare.
La mia famiglia era composta da mio padre, Stijepa, colonnello dell'esercito bosniaco, di etnia croata, mia madre Jana, tenente dello stesso esercito, serba, mia sorella, di due anni maggiore e io, arrivata per salvare il matrimonio dei miei genitori. La prima missione l'ho inevitabilmente fallita.
La mia città, Sarajevo, era bellissima. Abitavamo a Grbavica, un quartiere moderno, che oggi è famoso per essere stato la roccaforte dei serbi e dei loro cecchini. Ho visto sparare alle finestre, ai portoni, ai cani che passavano, alle persone che correvano. Ho visto morire per strada i miei vicini di casa, due compagni di classe, sconosciuti con i cappotti insanguinati, ho sentito il crepitio dei kalashnìkov sui muri dei palazzi, le urla di coloro che erano portati via con la forza.
Alla fine non c'era più nessuno a difenderci. Mio padre era stato dichiarato disperso e mia madre era sparita. Un giorno non è tornata a casa. La credevamo morta, ma guardando la Tv, che trasmetteva filmati girati nelle strade di Sarajevo e che in tanti guardavamo in cerca di persone care, mia sorella e io abbiamo visto una donna che c'è parsa la mamma. Un uomo l'aiutava e stava salendo su un mezzo di trasporto. Tutto questo avveniva in tempo reale nell'isolato accanto al nostro. Partiva per fuggire dalla guerra. Mi hanno detto che è viva e che abita a Belgrado.
Nella mia prima vita ho fatto la conoscenza con la razza dei giornalisti. Soprattutto gli americani. Venivano con i loro sorrisi a girare immagini dei " bambini di Sarajevo" che si sfamavano con una ciotola di latte della Croce Rossa. Tiravano fuori i loro snack, lattine e bibite senza mai offrire, regalare, barattare con un sorriso. Gli italiani erano un pochino diversi, ma tutti, proprio tutti, erano così interessati ai loro servizi da dimenticare che loro sarebbero partiti e noi rimasti lì senza la certezza del presente e, dunque, senza futuro.
Mi sentii male la prima volta in una serata di primavera. Dicevano che almeno il tempo stava volgendo al meglio quando un forte senso di nausea mi scagliò sul muro alle mie spalle. Sentivo caldo e mi sembrava di non respirare bene. Il prurito cominciò dal collo, poi le spalle, le braccia, le gambe, la schiena, il petto, il ventre, tutto prudeva, tutto bruciava, dentro e fuori. Mi condussero all'ospedale e diagnosticarono un avvelenamento da polveri, non meglio identificate. Snijézana riuscì a raggiungermi e restò per molti giorni seduta accanto al mio letto. Dormiva appoggiando la testa sul cuscino, accanto a me. Qualche volta si stendeva.
Miglioravo. Sapevamo che di lì a qualche giorno mi avrebbero dimesso per affidarci ad uno dei tanti centri di raccolta di profughi e orfani. Saremmo diventate un numero, magari consecutivo; non ci piaceva nemmeno un po'. Sentivamo parlare di stupri, di sparizioni, di quello che i Serbi continuavano a perpetrare nella nostra terra. Abbiamo visto donne di tutte le età, fantasmi a cui avevano tolto anche l'anima, raggomitolate in quei letti come fagotti, restare lì per giorni senza mangiare, senza piangere. Snijézana, che di noi due è la più saggia, mi diceva che in fondo eravamo fortunate, a noi non era toccato. Si presentò una mattina mio zio Marko, uno dei fratelli di mio padre. Ci portava nella Croazia pacificata, nel paese natale della mia famiglia, Elizavac, che è un piccolissimo villaggio dove metà della popolazione è nostra parente. Lì c'è mia nonna Anna che ci ha preso con sé e ci ha insegnato a vivere.
La mia seconda vita si alimenta di mia nonna. Oggi è quasi novantenne, analfabeta, ha visto più guerre che giorni di festa. Ha partorito sette figli, due morti alla nascita, uno nel conflitto contro i Serbi( mio padre), una in un incidente stradale e il piccolo Mirko, sparito cinquant'anni fa nel bosco vicino a casa. Sembra un'orribile favola, ma gli orchi esistono davvero. Quello è stato il dolore più grande della sua vita. Mia nonna Anna, che conosce acqua corrente ed elettricità solo da pochi anni, ci ha rimesso in sesto a forza di salsicce e fagioli conditi con preghiere e candele accese alla Madonna. Credo ancora in Dio( che per me significa speranza) per lei, che è la creatura più cara e dolce e forte sulla faccia della terra. In questa vita croata ho studiato nelle scuole dei paesi del circondario e ho vinto una borsa di studio per l'Italia. Grazie agli accordi fra il Bel Paese e la Croazia avrei potuto frequentare la scuola superiore a Milano. Vedevamo, senza comprenderne la lingua, i programmi e la pubblicità italiani pieni di persone belle ed eleganti, di città magnifiche e di gatti che mangiavano in scodelle dorate. Lasciai con dispiacere mia sorella, che ha continuato a studiare in Slovacchia, il Paese d'origine di mia nonna. Oggi si è laureata in lingue a Bratislava ed è tornata ad insegnare inglese e slovacco nelle scuole di Elizavac e dintorni.
Il viaggio verso l'Italia era carico di sogni e di attese. Avrei fatto parte di una famiglia con due figli, una ragazza e un ragazzo della mia età ( avevo sedici anni) e avrei studiato in un istituto tecnico con indirizzo turistico.
Mi accorsi ben presto che la lingua italiana era molto difficile e che non riuscivo ad impararla in fretta perché nessuno parlava con me. A scuola mi vedevano come una zingara o un'albanese sbarcata dal gommone, a casa ero costretta a passare il pomeriggio nella mia stanza, potevo uscire solo per la cena. La domenica dovevo andare a Messa con la famiglia ospite che esibiva, così, una volta la settimana, tutta la bontà dei sentimenti di accoglienza e il valore della solidarietà.
La mia terza vita è stata umiliante, ma sono testarda e non accetto facilmente la sconfitta. L'Italia è bella e io dovevo trovare il modo di scoprirlo. Anche la Jugoslavia ( che emozione chiamarla ancora in questo modo…) è bella, ma non esiste più e non volevo tornare in quell'inferno. Lo avevo giurato a me e a mio zio Marko che quando sono andata a trovarlo mi ha chiesto: " E allora, abbiamo scoperto quanto sono bravi gli italiani? Quei tre ancora vivi che non sono mafiosi!...".
In quattro anni ho cambiato altrettante famiglie. Mancava solo il quinto al diploma, quando gli accordi internazionali sono saltati e mi sono ritrovata in un Paese che mi considerava straniera, senza titolo di studio e senza possibilità che il governo croato convalidasse i miei anni di scuola. Ho trovato lavoro come baby-sitter presso una famiglia che gestiva una trattoria sui Navigli. La mattina spesso saltavo le lezioni perché la piccola di diciotto mesi di cui avevo cura mi faceva passare la notte in bianco; nel pomeriggio, quando dormiva, dovevo stirare le tovaglie del locale, per me c'era sempre qualcosa da fare.
Mi sono diplomata, ho trovato lavoro in una profumeria e sono andata ad abitare con altre tre ragazze in una vecchia casa dalle parti di Porta Venezia. Per la prima volta ho avuto una mia vita. Lavoravo, uscivo con gli amici e fra questi ho conosciuto Daniele che studiava in un'università prestigiosa e veniva da Lecce. La sera in cui l'ho incontrato avevo indosso un maglioncino di cotone per difendermi dal prurito, ma inspiegabilmente la sua compagnia mi rendeva quieta e fresca. Dopo pochi mesi sono andata a vivere con lui, ho trovato un lavoro fisso che ho deciso di abbandonare quando Dado si è laureato ed è tornato a casa per lavorare nella piccola azienda di famiglia. Gli amici mi hanno sconsigliato di mollare un impiego sicuro, di prendere tempo, ma chi ha un'esperienza come la mia sa che la felicità dura poco, pochissimo e che nulla, che si nutra di vita, è immutabile, ma neppure irreversibile. Il prurito era diminuito molto e respiravo meglio.
La mia quarta vita a Lecce è cominciata male. Gli affari di famiglia di Dado andavano sempre peggio, suo padre aveva troppi debiti. Ci siamo rimboccati le maniche. Lavoravo in una tavola calda e Dado, pian piano, con l'aiuto di uno zio ha cominciato a risolvere i problemi finanziari. I nostri rapporti erano tesi perché lui, che non era abituato a guadagnarsi il pane, pretendeva di vincere le ingiustizie.
Abbiamo una casa che ci ha messo a disposizione la nonna paterna, con noi c'è anche qualche amico e ora lavoro in un negozio di abbigliamento, a tempo indeterminato. Fare la commessa non è una gran cosa, ma mi permette di vivere e, poi, so che cambierà ancora. L' azienda di famiglia va meglio e credo che fra poco avrò la possibilità di impiegarmi in un ufficio della stessa ditta. Pensiamo al matrimonio, ai bambini che avremo, a mia sorella che la prossima estate verrà a trovarci con la mia prima nipotina che ha due anni e si chiama come me, Anja.
Qualche volta mi gratto e mi assale la paura che quei rigonfiamenti, quel bruciore possano tornare.
Francesca, la mamma di Dado, mi ha spiegato che le analisi dicono che le polveri inalate e prese per contatto durante la guerra non sembrano aver procurato veri danni. Che, in realtà cerco di "sfogarmi" per tutto quello che ho patito. Forse ha ragione. So che mi vuole molto bene e che vorrebbe stringermi fra le braccia, cullarmi, essere per me la mamma che non ho avuto. Glielo lascio fare solo un pochino, non perché non mi fidi ( non mi fido di nessuno) ma perché una figlia bisogna guadagnarsela. Chi la mette al mondo crede di avere le ragioni dell'amore e del sangue, chi la trova nel suo cammino deve accettare che sia solo lei a concedere il diritto di amarla. Francesca fa di testa sua e mi ama lo stesso.
L'altro giorno la pelle ha ricominciato a bruciare forte. Ho dovuto grattarmi e, benché abbia imparato a farlo con i polpastrelli, non ho potuto evitare di graffiarmi. Ho preso di nuovo i medicinali e mi sono chiesta cosa avessi respirato, o toccato. O ricordato. Non mi è venuto nulla in mente se non una musica che veniva dalla scuola di danza sotto casa mia. Una melodia orientale, un violino, forse il leit-motiv di una bella pellicola sull'ultimo imperatore cinese. A Sarajevo mio padre aveva alcune musicassette con le colonne sonore di film famosi, forse c'era anche quel brano così dolce e struggente. Le medicine hanno fatto effetto e il prurito è scomparso.
Leggo dei libri di psicologia, mi piacerebbe saperne di più sui meccanismi che tengono in equilibrio il corpo e la mente. Immagino che il mio problema sia una corazza, non un'armatura esterna, ma una latta interiore che blocca certi flussi, certi umori, che ristagnano e s' incendiano. Ne vorrei parlare con mia sorella e sapere se anche lei ha maglie e cotte che la legano.
Verrà in vacanza da me la prossima estate, porterà la mia bellissima nipotina e quel marito così alto con la faccia da slavo. Gli presenterò il mio ( non siamo ancora sposati) che ha un bel viso mediterraneo. Fingeremo di giocare a signore, come quando da bambine, nel cortile di un grande caseggiato, pensavamo di portare le nostre bambole in vacanza sui monti della Slovenia o sulla costa del Montenegro.